DA “FORNELLI D’ITALIA-150 ANNI DI STORIA DEL NOSTRO PAESE RACCONTATI DA PICCOLE E GRANDI DONNE” STEFANIA APHEL BARZINI-EDIZIONI MONDADORI
Ammazzacaffè
«Del mio castello io sono la regina / E il mio regno è la cu- cina / … / Voglio chiudermi nel frigo tra le fragole e le oli- ve Saclà / Non c’è un altro posto al mondo ora / Che mi fa star meglio della mia cucina…»
No, non si tratta di una rivisitazione della favola di Ce- nerentola, costretta dalla malasorte a vivere tra i fornelli. È invece una storia di oggi, Irene Grandi che canta un mo- mento di tristezza, un mondo che le è ostile, e l’unico angolo dove trovare conforto alla sua solitudine è la cucina, i suoi rumori, quello del frigorifero dove rinchiudersi tra fragole e olive, del caffè che brucia sul gas.
Sono passati anni, e sembrano secoli, da quando Mina cantava di un luogo dove non entrare mai se non per sbaglio. Cosa è allora accaduto di noi, del nostro rapporto con il cibo, con pignatte e casseruole?
Fino all’Ottocento abbiamo abitato le cucine come serve- cuoche, buone a fare il bucato, a spazzare in terra, a spen- nare polli e a prendere ordini da chi deteneva il vero potere, gli chef. Siamo poi, con il nuovo secolo, diventate gli «angeli del focolare», le «regine della casa», un regno fatto di fornelli, di pentole, di padelle, perché è solo lì, che potevamo trovare o ritrovare la nostra identità. In realtà, di nuovo, il vero regnante, sua maestà, resta sempre «lui», lui che deve essere conquistato, addomesticato, lusingato, passando per lo stomaco, noi, al massimo, potevamo ambire al ruolo di «sacerdotesse del santuario».A ripetercelo come un mantra sono stati gli stessi giornali femminili: «Essa è la custode del santuario domestico e trovo giusto che la sacerdotessa sia nel tempio pronta a ricevere i fedeli. Quando il marito rincasa a colazione o a pranzo è un’impressione sfavorevole per lui non trovare sul limitare la moglie a dargli il benvenuto. Vi ha anche un’altra questione, in tutte le case non si ha la fortuna di possedere uno chef di prim’ordine; orbene l’occhio della padrona di casa serve a far sì che il pasto sia più gustoso e meglio servito».
A chi quel santuario avesse avuto voglia di disertarlo si è risposto minacciando scenari cupi, guai e disastri in famiglia. La colpa si sarebbe di certo abbattuta su di noi, ree di una cucina malfatta: «Le vivande mal cucinate danno origine a disordini in molte famiglie, molte liti, molti scontri, molte collere non trovano forse la loro causa in un arrosto bruciato? In un brodo insipido? In una minestra cattiva? Al contrario quanta allegria, quale conforto può dare un pranzo ben curato! Quando in una casa mancano una brava moglie e una brava figlia l’uomo finisce col cercare conforto all’esterno, nei club, nei circoli, nelle osterie, pessimi prodotti della civiltà moderna, cause dell’allentarsi dei legami della famiglia; per fare sì che l’uomo preferisca le pareti domestiche, la donna deve ricordarsi del suo diritto fondamentale, quel diritto che è tutto nostro esclusivo, di sacrificarci per il bene della famiglia, di essere gli angioli custodi della casa, di amare e farci amare … Per questo ci vuole meno fosforo nel cervello e più sangue nel cuore, meno nervi e più muscoli, meno diritti e più doveri, meno teorie emancipatrici e più pratica … di cucina».
Dunque non solo non c’è scampo al di là di mestoli e padelle, ma dobbiamo anche ficcarci in testa che sacrificarci per i nostri cari non è, come ci è stato ripetuto per secoli, un dovere. Ora è diventato addirittura un diritto da rivendicare con orgoglio.
Ci sono stati poi il fascismo e le guerre, la ricerca affannosa del cibo e dei mille modi per mettere insieme un pasto appena decente. Con il boom economico ci siamo trasformate in svampitelle, buone a poco senza gli aiuti esterni e infi- ne, stufe, dai fornelli siamo fuggite, senza troppi rimpianti. Abbiamo messo in discussione, scandagliato, osservato, tutto ciò che per secoli ci ha condizionate, oppresse, limitate: tabù, educazione, sesso, famiglia, lavoro, figli, la sola cosa che ci ostiniamo a non analizzare sono i nostri rapporti con il cibo e i gesti del nutrire. Per anni pignatte e casseruole sono state vietate, e a interdirle ci abbiamo pensato da sole, mostri cattivi, armi pericolose, simboli solo di soggezione, prevaricazione, disagio. Ancora oggi siamo poche a interrogarci su questo ostinato rifiuto.
Molto invece si dibatte e con grande accanimento, sul primato della cucina degli uomini o di quella delle donne. Un dibattito senza senso. Un dibattito che, di nuovo, è impostato in termini molto maschili: chi è più bravo, chi vince la gara, chi fa arte e chi invece mestiere. Insomma la solita competizione, e anche tra le più noiose. Recentemente su un forum ci si è interrogate sui motivi per i quali ai fornelli dei ristoranti ci siano così poche donne chef, e un blog di un quotidiano nazionale, dedicato a tematiche femminili, ha postato un lungo articolo sul ruolo delle donne nella ristorazione, arrivando a concludere che l’arte culinaria femminile, se ben fatta, può vincere su quella maschile. Ci sarebbe da obiettare a entrambi gli interventi. Di donne chef ce ne sono e ce ne sono sempre state, anche ai massimi livelli. Sono di certo meno vistose degli uomini, in genere fanno, e bene, il loro lavoro, senza porsi il problema di chi sia meglio e chi sia peggio, hanno ego meno ipertrofici di quelli dei loro colleghi maschi, sono di solito meno cerebrali, meno tese a creare l’opera d’arte o a raggiungere la perfezione stilistica e, al contrario di questi ultimi, cercano meno visibilità mediatica. Agli schermi televisivi, alle pagine dei giornali, ai convegni (sarà forse un caso che all’edizione di «Identità Golose» del 2013, il convegno in cui si incontrano, spadellano e discutono chef di tutto il mondo, di donne ce ne fosse soltanto una?) preferiscono le loro cucine.
Perché infatti pensare che debba esistere una supremazia di questo o quell’altro sesso? Perché non rivendicare invece le «diversità»? Ci sono brave cuoche e pessimi cuochi, e viceversa. Porre sempre tutto in termini di sfida è una modalità che poco ci appartiene.
Siamo semplicemente diversi. Abbiamo atteggiamenti diversi. Cuciniamo in maniera diversa. Né meglio, né peggio. Di questa diversità tra le pentole bene scrive Irène Frain, francese, autrice tra gli altri di un delizioso piccolo libro dal titolo rivelatore: La felicità di fare l’amore in cucina e viceversa in cui racconta il suo desiderio di riappropriarsi di un’identità perduta: «Non negherò l’evidenza, (la mia felicità in cucina) è, in qualche modo, il piacere inconscio di mostrarmi fedele alla distribuzione arcaica dei ruoli tra i due sessi, la voluttà di mostrarmi conforme a un antichissimo condizionamento sessuale. E allora? Le gioie della maternità sono della stessa natura. … Ho scelto dunque la mia felicità in cucina. La assumo, di conseguenza, perfino nei suoi momenti di fatica, di collera e nei giorni di irrita- zione in cui decido che è troppo, che oggi sarei stata io a dover essere servita, che bisognerà far ricorso ai surgelati o al rosticciere sotto casa». E prosegue raccontando la diversità degli uomini ai fornelli: «Rientra dal mercato come dalla caccia. Muscoli tesi, schiena irrigidita: ha assunto la postura del guerriero. Trasformerà la cucina nel teatro di una nuova lotta. D’altronde, eccolo già intento a disimballare,preparare,condire le vettovaglie: ha l’occhio fisso del predatore. I suoi sono gesti più chirurgici che amorosi. Concentrazione estrema. Spesso tace,mentre la cuoca, da parte sua, può parlare per ore al di sopra dei suoi fornelli. Lui no: si tratta di qualcosa di serio. Di una guerra. È assolutamente indispensabile che ne esca vincitore. Il fuoco e l’acqua sono suoi alleati, non dei complici».
Meglio sarebbe quindi cercare un incontro, non uno scontro. L’inutilità di siffatta polemica è evidente già dai commenti all’articolo postato. Che sono di imbarazzan- te tristezza. Da una parte gli uomini che rivendicano la loro egemonia in termini che fanno dubitare dell’intelligenza di chi scrive: «Per la mia esperienza le donne hanno un gusto troppo semplice e la mano troppo delicata», «L’uomo osa di più», «La donna è fisicamente più debole, non è autosufficiente, rallenta il lavoro, crea disagio a una brigata di uomini, e non va d’accordo con le altre donne perché è competitiva, egocentrica e gelosa. E non sa usare i coltelli» (Chissà come faranno le donne, ogni giorno, nelle loro case a tagliare verdure, affettare prosciutti, sfi- lettare pesci, tritare la carne…). E ancora: «La donna è donna giusto? [Verità difficile da confutare.] Quindi è tendenzialmente isterica, mediamente permalosa e ha il ciclo mestruale. È poco incline a subire il trattamento tipico da brigata e non ha la stoffa per essere un buon leader. Resta incinta, [l’eterna colpa femminile: voler mettere al mondo figli], si ammala spesso, ha una bassa tolleranza al dolore fisico e si lamenta [d’altronde è da sempre risaputo: la donna è mobile, qual piuma al vento, ecc.]». Per finire in bellezza: «Non ci sono molte donne che fanno le cuoche perché le donne non sono capaci, mi sembra evidente. Le donne devono lavare, stirare, mettere a posto la casa, crescere i figli e nel tempo libero fare le segretarie, le addette ai call center, le commesse, le cameriere finché sono carucce, e se sono bone le escort».
Insomma, come sottolineano anche Carlo Cracco e Bruno Barbieri, chef famosi, nonché due dei giudici del programma cult Masterchef, le donne creano scompiglio e in cucina non hanno la stessa verve degli uomini. Tralasciando qualsiasi commento in merito, (il gioco sarebbe troppo facile), non si può non notare che dai primi del secolo scorso poco è cambiato sotto il cielo maschile.
Dall’altra parte stanno le donne, giustamente risentite, che a chi afferma che quasi mai abbiamo lasciato segni tangibili e memorabilia del nostro passaggio, ribattono con altrettanti logori cliché, ricordando millenni di soprusi e sottomissione e sottolineando l’esistenza di figure femminili geniali che, nonostante tutto, hanno dato un significativo contributo alla società e alla scienza. I nomi, con scarsa fantasia, sono sempre gli stessi: Marie Curie, Rita Levi Montalcini, Margherita Hack, la regina Teodolinda e, in particolare, siamo pur sempre italiane, «lei», «la mamma» che dà la vita. E il dibattito va allegramente va ramengo.
Ciò che è poi davvero difficile da capire è la strana dicotomia per la quale l’universo maschile ci apprezzi quando cuciniamo nelle case e ci disprezzi invece una volta che ci cimentiamo ai fornelli di un ristorante. Una delle frasi che spesso sentiamo ripetere dai nostri uomini è: «Certo in nessun ristorante si mangia così bene come nelle case di chi cucina bene». Soprattutto se ai fornelli c’è la mam- ma. E dunque? Misteri insondabili dell’animo maschile.
Allora forse è arrivato il momento di riprenderci pentole e padelle, a prescindere da cosa ne pensino gli altri. Maschi o femmine che siano. Il momento di smettere di guardare questo luogo amato-odiato, questo antro della strega, come il simbolo del nostro isolamento, della nostra prigionia. Se ad aver cambiato idea è addirittura Rose Boycott, giornalista inglese e femminista storica che nel 1970 scriveva nel suo magazine «Spare Rib» contro ogni singolo istante passato ai fornelli, e che oggi ci ha ripensato e ammette sul «Guardian»: «Per il nostro modo di pensare, cucinare era per persone frivole e politicamente pericoloso. Ma ci sbagliavamo», perché quindi non possiamo farlo anche noi? La verità è che non abbiamo mai «scelto» di abitare le cucine, siamo piuttosto state costrette, non abbiamo maifatto nostro un ruolo che è solo nostro, che ci identifica e ci rappresenta: quello di nutrice, una parola che non ha un equivalente maschile. E rifiutare un ruolo che identifica è sempre doloroso e pericoloso. Altri sfamano, noi nutriamo.
Se abitare i fornelli è fatto con coscienza, per scelta, diventa un atto liberatorio e chi questa scelta l’ha già fatta, sa quanta libertà, quanta creatività possono regalare pentole e padelle.
Certo, si obietterà, ma il tempo, sempre tiranno, come fare a trovarlo? A pensarci bene anche questa faccenda del poco tempo è un’imposizione che arriva dall’esterno, ci hanno fatto credere che cucinare sia un atto lungo e faticoso, e di conseguenza che sia molto più semplice che a occuparsene ci pensi un’industria sempre più invadente. Noi ci abbiamo creduto o abbiamo fatto finta di crederci.
Un piatto di pasta, un’insalata, due polpette, si fanno in dieci minuti, e con pochissimo sforzo. Certo, ogni atto ripetitivo diventa noioso. Certo, le nostre vite sono complicate, tese a dimostrare che «Women can have it all», che possiamo avere ogni cosa, casa, carriera, figli, amici, marito, hobby. Uno degli imperativi più frustranti di questi ultimi anni, perché tutto nessuno riesce mai ad averlo. E allora non sarebbe invece liberatorio poter finalmente dire che no, non vogliamo affatto tutto, che vorremmo poter scegliere cosa debba o non debba far parte della no- stra vita e farlo senza condizionamenti esterni?
Non ognuna di noi sceglierà i fornelli, ma prendere possesso della cucina, farla diventare un luogo di azione e non più di reclusione, vuol dire riscoprire, dare valore e finalmente poter apprezzare, la nostra indole.
Una parte profonda e trascurata, la maga che prepara filtri, incantesimi, pozioni. Che trasferisce qualcosa di sé in ciò che bolle in pentola. Che si riappropria di poteri dimenticati ma sempre presenti nel proprio Dna. Che riafferma un codice genetico tramandato per millenni. Che rinnova la gioia di procurarsi il cibo, di dare cibo, di maneggiare cibo, di godere del cibo. Che ritrova un suo ruolo storico, sociale, politico e mai sufficientemente riconosciuto, quellodi depositaria della memoria gustativa del suo paese. Che è consapevole di una verità inconfutabile: la felicità è anche in cucina e la cucina è anche felicità. Che il cibo, prepararlo, trasformarlo, consumarlo, è gioia e allegria.
E che non c’è nulla di sbagliato nel lanciare al mondo un antico ma nuovo grido di guerra: «Tremate, tremate, le cuoche son tornate!».
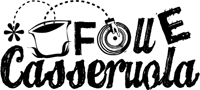

No Comments