IL PRIMO CAPITOLO DEL MIO PRIMO LIBRO “UNA CASALINGA AD HOLLYWOOD-SPLENDORI E MISERIE DELL’AMERICA CHE MANGIA”-STEFANIA BARZINI- EDIZIONI GUIDO TOMMASI
E’ stato il primo libro che ho scritto, volevo raccontare l’America, paese in cui ho vissuto sei anni, a Los Angeles. L’America l’ho adorata e tuttora l’adoro. L’ho anche molto odiata. Ma l’America è parte ormai di me e non posso non esserle riconoscente. E’ grazie a lei che ho capito che potevo fare quello che amavo: occuparmi di cibo e cucina. Gli Americani mi hanno accolto con entusiasmo, mi hanno insegnato ad osare e a credere in me stessa. Amo moltissimo il mio paese ma qui la mia strada l’avrei trovata con molte maggiori difficoltà. In America ci torno spesso, ho tanti amici lì, ed ogni volta è una festa, per me perchè posso riabbracciarli, per gli amici perchè sanno che cucinerò per loro. Sono felice di essere tornata a casa, ma l’America mi manca ogni giorno.
“Io l’America l’ho conosciuta mangiando. Nel vero senso della parola.
Mangiare mi è sempre piaciuto, fin da bambina il cibo ha avuto per me un’importanza particolare, anzi spesso è stato proprio attraverso la cucina e il mangiare che imparato a capire il mondo intorno a me: le case felici erano quelle in cui la pasta era sempre al dente e la rosetta croccante al punto giusto, le festicciole di bambini erano divertenti solo se c’erano i panini all’olio con il burro, il salame e la cioccolata calda con panna, i compagni di scuola migliori, quelli che per merenda avevano la pizza rossa sottile e croccante o la ciambella fritta. Insomma una vera e propria ossessione.
Non c’è perciò da meravigliarsi se anche lo studio della geografia rispondesse agli stessi criteri: la Francia mi piaceva perchè i francesi sapevano mangiare, la Germania invece non l’amavo affatto, non tanto per ragioni storico-politiche, ma per la triste uniformità dei suoi menu. E l’America? Qui il discorso si faceva più difficile, tutte le (scarse) informazioni sul continente americano venivano infatti dalla televisione.
Faccio parte di quella generazione che gli Americani chiamano dei “baby boomers”, quella cioè nata non molto dopo la fine della Guerra. Siamo cresciuti con un unico canale televisivo all’interno del quale due soli erano i programmi a cui avevamo libero accesso: la Tv dei Ragazzi, un’ora pomeridiana di telefilm e cartoni animati, e Carosello, l’invalicabile zona di confine giorno-notte per i bambini degli anni ’50. Le pubblicità di Carosello erano ancora in quegli anni molto casarecce, un universo che riguardava perlopiù salamini, formaggini, cera, caffè e, massimo dell’esotismo, il brandy Cavallino Rosso. Restava perciò la Tv dei Ragazzi. Quelli della mia generazione sanno di cosa parlo: Rin Tin Tin, Penna di Falco e Lassie, i tre capisaldi dei nostri pomeriggi televisivi. Quella per me era l’America. Ed era, bisogna dirlo, un paese ben strano, soprattutto per chi, come me, cercava di conoscerla attraverso il cibo.
Rin Tin Tin, l’eroico pastore tedesco, e il suo padrone Rusty, a quanto ricordo io, mangiavano pochissimo. E fin qui niente di anormale, i due erano soldati e l’esercito, si sà, mangia poco e male ad ogni latitudine.
Più complessa era invece la lettura di “Penna di Falco, Capo Cheyenne”. Si trattava del primo Indiano “politically correct” nella storia della televisione mondiale: un gigantesco Cheyenne, pelle molto rossa (le truccatrici dell’epoca non erano un granchè), lunghe trecce nere, l’immancabile copricapo di penne. Penna di Falco parlava pochissimo, usava i verbi solo all’infinito e la sua frase preferita era “Augh!”.
Per ciò che riguarda il cibo, poca roba, qualche pezzo di carne cotta allo spiedo sotto le stelle. Da lui perciò non appresi molto, se non che l’America doveva essere un paese molto caldo o molto povero: il capo indiano infatti andava sempre in giro a torso nudo, estate o inverno.
Per fortuna però c’era Lassie, il mio telefilm preferito. Lassie, il prodigioso collie, era la prova vivente di ciò che avevo cominciato a sospettare: i cani americani erano intelligentissimi, i loro padroni un pò meno. Nè io nè i miei fratelli siamo mai riusciti a capire di cosa vivesse quella gente. Lassie era infatti l’unico componente della famiglia ad avere un vero lavoro che consisteva nel salvare esseri umani che immancabilmente si ficcavano nei pasticci. C’era poi Paul (il padre), che trascorreva il suo tempo sdraiato sotto un trattore sempre rotto ( la “famiglia Lassie” doveva essere povera, molto povera, altrimenti non si spiegava perchè non comprassero un trattore nuovo). Timmy(il figlio) faceva quello che fanno tutti i bambini di questo mondo, giocava. Ogni volta che Lassie scopriva qualcuno in difficoltà cominciava ad abbaiare frenetico, cercando di attirare l’attenzione dei suoi padroni e inevitabilmente, ogni volta, Tim e Paul si guardavano perplessi domandandosi: ” Credi che ci sia qualcosa che non va?” oppure” Cosa pensi che stia cercando di dirci?” . A questo punto a casa mia scoppiava la bagarre: ” Ancora! Ma non è possibile! Ma è una famiglia di cretini!” Urlavamo al televisore io e i miei fratelli.
Il personaggio che amavo di più però era Ruth (la madre). Questa Ruth era una giovane signora sempre un pò preoccupata ( e come darle torto visto i famigliari che le erano capitati?), indossava sempre un unico indumento, il grembiule, viveva in un’unica stanza, la cucina, e preparava instancabile un unico menu, polpettone e patate sempre seguite da una torta ripiena. Ruth e la sua casa mi rassicuravano: immaginavo che l’America fosse un paese di mamme dedite alla cucina e ai loro cari, sempre pronte a mettere in forno un nuovo dolce. Potevo quasi sentire il profumo caldo e accogliente dei piatti in tavola. Gli Americani perciò mangiavano ed erano felici.
Questa prima, importante informazione etico-culinaria mi venne poi successivamente confermata. Oltre alla televisione infatti l’altra mia fonte di notizie erano i fumetti. Paperopoli era la mia città malgrado i suoi abitanti mi lasciassero un pò perplessa. Le parentele erano confusissime: molti zii, cugini e nipoti, ma dov’erano andati a finire i genitori? Tutti poi vivevano d’aria. Il più ricco, Zio Paperone, passava la giornata tuffandosi nei suoi denari (non si sa guadagnati come), gli altri non avevano professioni conosciute tranne Archimede Pitagorico e lei, l’ineguagliabile Nonna Papera. Nonna Papera aveva una fattoria, tanti animali e soprattutto cucinava, solo torte è vero, ma il suo, si capiva, era un universo felice, tutto tendine alle finestre, tavole apparecchiate e per l’appunto dolci appena sfornati. Questa per me la prova definitiva che l’America fosse un paese che poteva entrare di diritto nel mio particolare universo geografico-culinario. Certo qualche dubbio ogni tanto mi assaliva. Perchè Ruth cucinava solo polpettoni e stufati? E come mai le torte di Nonna Papera erano tutte uguali? Insomma il panorama gastronomico americano mi sembrava un pò piatto. Ma erano solo momenti. Nel mio immaginario, per molti anni ancora, l’America avrebbe occupato lo spazio di una nebulosa costellata di cani prodigio e paperi parlanti.
Poi qualcosa cambiò. All’inizio degli anni ’60, la mia famiglia, colpita da repentino benessere, decise di traslocare. La casa dove ero nata e cresciuta con i suoi vecchi parquet scricchiolanti era improvvisamente diventata troppo piccola e il tranquillo e rassicurante quartiere della mia infanzia non era forse una cornice sufficentemente elegante ai sogni di gloria di mio padre. Adesso era di moda vivere nelle “zone residenziali”, quelle periferie ricche, molto verdi e un pò anonime che crescevano come funghi soprattutto nella parte nord della mia città. Così ci trasferimmo in una grande casa piena di luce, di terrazze, di saloni di rappresentanza, in cui ognuno di noi figli aveva la propria stanza e i propri spazi. Non mi affezionai mai a quella casa, troppo grande, troppo nuova, completamente sprovvista di quegli spazi misteriosi che sono l’anima di una vera casa. “Fuori” però il discorso cambiava. “Fuori” c’era la campagna, c’erano prati, boschi, fiumiciattoli, grotte misteriose. Sparivamo per giornate intere ad esplorare i confini di un mondo che ci sembrava solo nostro. E poi c’erano gli stranieri. Soprattutto gli Americani che, come ho poi scoperto in seguito, amavano poco le città e molto le loro periferie, quelle zone intermedie tra la metropoli e la campagna, l’illusione di una rassicurante frontiera. E così facemmo la conoscenza dei nostri primi “Yankees”. Jimmy e Charlie erano due fratelli tra cui c’era poca differenza d’età, si assomigliavano moltissimo e da subito diventarono per noi un’unica identità, “JimmyeCharlie, gli americani”. Ci sembravano il massimo dell’esotismo. Intanto andavano a scuola (americana) con il pulmann che li prendeva e li riportava sotto casa ogni giorno. E poi ero innamorata della loro divisa, pantaloncini bermuda di flanella grigia, la giacchetta bordeaux con lo stemma dorato e la cravatta grigia. Che contrasto con le nostre tristissime divise blu con il colletto bianco! E poi nella loro casa i due fratelli avevano “il basement”, una stanza solo loro, dove giocavano e ricevevano i loro amici:noi. E con JimmyeCharlie si giocava, ossessivamente, ad un unico gioco. Niente avventure nei boschi intorno a casa con loro, niente corse, niente “gioco del dottore” che tra noi fratelli andava fortissimo. JimmyeCharlie amavano solo il Monopoli. Partite interminabili in cui noi, da bravi Italiani perdevamo sempre, ma non era importante. Quello che ci piaceva era guardare con quanta passione accumulavano i loro soldi finti, in piccole pile ordinate, e con che gioia piazzavano un numero esorbitante di case e alberghi nelle loro proprietà. JimmyeCharlie sono stati una breve meteora nella nostra vita, non ne abbiamo saputo più niente. Di una cosa però sono sicura: dietro l’angolo li attendeva un glorioso futuro di agenti immobiliari. I pomeriggi passati a casa dei nostri amici americani erano molto diversi dai nostri: c’era sì una mamma ( e stranamente non portava mai il grembiule) ma compariva pochissimo e per merenda niente panini con la marmellata o con il prosciutto, bensì (a prova definitiva della loro inarrivabile superiorità), pop corn e coca cola! Il destino però è cinico e baro, e un giorno accadde l’irreparabile. Un pomeriggio, la silenziosa mamma di JimmyeCharlie, interruppe la nostra partita a Monopoli per offrirci un vassoio di tartine: “le ho fatte io!”, ci disse con orgoglio. Mio fratello, sempre un pò sospettoso per ciò che riguarda il cibo le annusò e mi disse piano: “hanno uno strano odore…” Io più avventurosa ne infilai una in bocca con disinvoltura e….fu come se un missile terra-acqua si fosse schiantato sulle mie papille gustative. Qualcosa di pastoso e oleoso allo stesso tempo si era attaccato al mio palato e come cemento a presa rapida l’aveva sigillato ermeticamente. Mentre mugolavo con gli occhi sbarrati, la mamma, forse scambiando i miei rantoli per mugolii di piacere mi disse sorridendo: “E’ peanut butter, burro di noccioline!”. Tentati disperatamente di inghiottire quella specie di palla di ovatta sorridendo e invece…feci qualcosa di cui mi vergogno ancora oggi; vomitai tutto sulla moquette del basement di JimmyeCharlie, sotto i loro occhi inorriditi. E non riuscii neanche a mormorare delle scuse, balbettai solo un imbarazzato :”Ma è spaventoso!” più diretto al burro di noccioline che a ciò che avevo appena fatto e scappai a casa. La love story con JimmyeCharlie non fu scalfita dalla mia tremenda performance ma il dubbio, quello che da anni dormicchiava in un angolo della mia mente si risvegliò di colpo:”Come è possibile?” continuavo a ripetermi”Come è possibile che la natura produca un simile orrore, e che loro non solo lo mangino ma che lo trovino anche buonissimo?” Non mi davo pace. E le mie ansie non si placarono quando, pochi anni dopo mio padre tornò dall’America. Era la prima volta che uno della mia famiglia si avventurava nel nuovo continente. Mio padre aveva trovato un’offerta speciale che lo avrebbe portato a New York per 4 giorni, in occasione di un incontro di pugilato. Attendavamo con eccitazione il suo ritorno e i suoi racconti. Che invece furono quanto mai succinti: “L’America è un Paese violento, dove la gente è molto sola, spesso perciò gli Americani si buttano dalla finestra o si ammazzano tra di loro. Sono stato anche ad Harlem.” Punto. Immaginavo New York come una città in cui fosse difficile camminare per strada visto il numero impressionante di persone che si lanciavano nel vuoto. Se le informazione erano state scarse a confondermi ulteriormente le idee c’erano però gli oggetti che mio padre aveva riportato dal suo viaggio. Un’accozzaglia di aggeggi curiosi. C’era un ozonizzatore di cui non si capiva l’utilità e una serie impressionante di pesantissimi salvadanai in ferro, una sorta di teatrini al cui interno un uomo, nerissimo, dalle smisurate labbra bianche, inghiottiva monete grazie ad una levetta che lo metteva in movimento. Mio padre doveva evidentemente esserne affascinato perchè ne aveva acquistati almeno 20. E per noi figli c’erano confezioni magnum di strani dolcetti morbidi, della consistenza di una piccola spugna e il sapore di saponette profumate. “Questi sono i dolci preferiti dei bambini americani”, c’era stato detto. Marshmallow e peanut butter, tutto congiurava al formarsi di un’immagine un pò inquietante della mia America. “Forse-mi ripetevo- forse sono solo i bambini americani ad essere un pò strani, gli adulti sono un’altra cosa”. Provammo in tutti i modi a migliorare la qualità delle nostre toffolette, le arrostimmo allo spiedo, come avevamo visto fare a Charlie Brown, le sciogliemmo nella cioccolata calda. Niente però poteva cambiare la realtà: stavamo mangiando del bagno schiuma.
nelle loro proprietà. JimmyeCharlie sono stati una breve meteora nella nostra vita, non ne abbiamo saputo più niente. Di una cosa però sono sicura: dietro l’angolo li attendeva un glorioso futuro di agenti immobiliari. I pomeriggi passati a casa dei nostri amici americani erano molto diversi dai nostri: c’era sì una mamma ( e stranamente non portava mai il grembiule) ma compariva pochissimo e per merenda niente panini con la marmellata o con il prosciutto, bensì (a prova definitiva della loro inarrivabile superiorità), pop corn e coca cola! Il destino però è cinico e baro, e un giorno accadde l’irreparabile. Un pomeriggio, la silenziosa mamma di JimmyeCharlie, interruppe la nostra partita a Monopoli per offrirci un vassoio di tartine: “le ho fatte io!”, ci disse con orgoglio. Mio fratello, sempre un pò sospettoso per ciò che riguarda il cibo le annusò e mi disse piano: “hanno uno strano odore…” Io più avventurosa ne infilai una in bocca con disinvoltura e….fu come se un missile terra-acqua si fosse schiantato sulle mie papille gustative. Qualcosa di pastoso e oleoso allo stesso tempo si era attaccato al mio palato e come cemento a presa rapida l’aveva sigillato ermeticamente. Mentre mugolavo con gli occhi sbarrati, la mamma, forse scambiando i miei rantoli per mugolii di piacere mi disse sorridendo: “E’ peanut butter, burro di noccioline!”. Tentati disperatamente di inghiottire quella specie di palla di ovatta sorridendo e invece…feci qualcosa di cui mi vergogno ancora oggi; vomitai tutto sulla moquette del basement di JimmyeCharlie, sotto i loro occhi inorriditi. E non riuscii neanche a mormorare delle scuse, balbettai solo un imbarazzato :”Ma è spaventoso!” più diretto al burro di noccioline che a ciò che avevo appena fatto e scappai a casa. La love story con JimmyeCharlie non fu scalfita dalla mia tremenda performance ma il dubbio, quello che da anni dormicchiava in un angolo della mia mente si risvegliò di colpo:”Come è possibile?” continuavo a ripetermi”Come è possibile che la natura produca un simile orrore, e che loro non solo lo mangino ma che lo trovino anche buonissimo?” Non mi davo pace. E le mie ansie non si placarono quando, pochi anni dopo mio padre tornò dall’America. Era la prima volta che uno della mia famiglia si avventurava nel nuovo continente. Mio padre aveva trovato un’offerta speciale che lo avrebbe portato a New York per 4 giorni, in occasione di un incontro di pugilato. Attendavamo con eccitazione il suo ritorno e i suoi racconti. Che invece furono quanto mai succinti: “L’America è un Paese violento, dove la gente è molto sola, spesso perciò gli Americani si buttano dalla finestra o si ammazzano tra di loro. Sono stato anche ad Harlem.” Punto. Immaginavo New York come una città in cui fosse difficile camminare per strada visto il numero impressionante di persone che si lanciavano nel vuoto. Se le informazione erano state scarse a confondermi ulteriormente le idee c’erano però gli oggetti che mio padre aveva riportato dal suo viaggio. Un’accozzaglia di aggeggi curiosi. C’era un ozonizzatore di cui non si capiva l’utilità e una serie impressionante di pesantissimi salvadanai in ferro, una sorta di teatrini al cui interno un uomo, nerissimo, dalle smisurate labbra bianche, inghiottiva monete grazie ad una levetta che lo metteva in movimento. Mio padre doveva evidentemente esserne affascinato perchè ne aveva acquistati almeno 20. E per noi figli c’erano confezioni magnum di strani dolcetti morbidi, della consistenza di una piccola spugna e il sapore di saponette profumate. “Questi sono i dolci preferiti dei bambini americani”, c’era stato detto. Marshmallow e peanut butter, tutto congiurava al formarsi di un’immagine un pò inquietante della mia America. “Forse-mi ripetevo- forse sono solo i bambini americani ad essere un pò strani, gli adulti sono un’altra cosa”. Provammo in tutti i modi a migliorare la qualità delle nostre toffolette, le arrostimmo allo spiedo, come avevamo visto fare a Charlie Brown, le sciogliemmo nella cioccolata calda. Niente però poteva cambiare la realtà: stavamo mangiando del bagno schiuma.
Non ci pensai più. Passarono gli anni, arrvò il ’68, la politica, i cortei, il Vietnam. Gastronomicamente parlando sono stati anni cupissimi, il rivoluzionario si sà non ama mangiare, troppo borghese, e io non facevo eccezione. Pesavo pochissimo e mangiavo malissimo. In quegli anni i pasti si consumavano sempre di fretta, tra una riunione e l’altra. C’erano cose molto più importanti a cui pensare. L’atteggiamento di noi Europei nei confronti dell’America era completamente schizofrenico: odio viscerale per il suo establishment, il suo presidente e il suo esercito, da una parte; ammirazione e anche una certa invidia per “l’altra America”, quella dei campus in rivolta e delle manifestazioni contro la guerra, dall’altra. E poi una passione smodata: quella per il cinema americano, nella sua interezza. Dalle vecchie comiche, Buster Keaton e Harold Lloyd in testa, ai noir degli anni ’40, al nuovo cinema giovanile. “Easy Rider”, “Conoscenza Carnale”, “Quattro pezzi facili”, “Fragole e Sangue” (non ho mai capito il perchè delle fragole), li avevamo visti tutti almeno 20 volte, ne conoscevamo a memoria musica e battute. Il cinema Farnese era uno dei migliori cinema d’essai della mia città. Riproponeva sempre gli stessi film e noi non ci stancavamo mai di rivederli. In particolare “Fragole e Sangue” era diventato un “cult”. La scena della carica della polizia all’Università non smetteva di elettrizzarci. il cinema si trasformava ogni volta in un campo di battaglia. Urla, slogans, lancio di bottiglie e lattine contro lo schermo, una volta fu scaraventato addirittura un sedile. Insomma una compartecipazione totale con i compagni americani dall’altra parte della barricata. Finchè, esausto, il proprietario accese le luci in sala e guardandoci negli occhi ci disse tristemente: “Ahò!!E’ finto! E’ un “Firm”!. Beh per noi era assolutamente vero e la bagarre riprese peggio di prima. Finchè il cinema chiuse.
E poi venne il momento di andarci veramente in America. A vedere come andavano le cose. Anche gastronomicamente parlando. Primi anni ’80, il panorama era cambiato, la rivoluzione dormiva sonni tranquilli. Io avevo messo su famiglia. Decidemmo con Andrea, mio marito, di partire con i nostri figli, Chiara e Matteo, allora 7 e 4 anni, per una vacanza “on the road”, aereo e macchina: 1 mese e mezzo in giro per il vecchio West alla ricerca della “nostra America”. E fu amore a prima vista. Non più quello infantile per JimmyeCharlie. No, un amore vero e assoluto per un intero paese, il famoso colpo di fulmine a cui non avevo mai creduto. Fin dal primo istante, da quando in macchina, appena sbarcati all’aereoporto di Newark, guardavo rapita sfilare le mille casette tutte uguali e tutte piuttosto tristi, ognuna con il suo piccolo backyard, il suo barbecue e la sua brava bandiera americana. In realtà si trattava di sobborghi abbastanza squallidi ma per qualche motivo che non sono mai riuscita a spiegarmi, in America il brutto ( e di brutto ce ne è moltissimo) è talmente brutto da diventare quasi bello. Come una qualsiasi donna in preda ad una sconvolgente passione amorosa passai tutto il viaggio, 48 giorni, in preda ad un’esaltazione continua. Tutto mi sembrava eccitante e meraviglioso. Le enormi macchine, le strade, i cieli più grandi che avessi mai visto in vita mia, le città, tutte, anche quelle che se le avessi visitate in Europa avrei avuto un moto di orrore. Ma soprattutto quello che mi conquistò definitivamente e per sempre fu la natura. Distanze immense, foreste così profonde dove perdersi per tutta la vita, deserti assolati in cui guidare per ore senza incontrare essere umano, spazi sterminati che suggerivano dimensioni diverse del tempo, non solo di quello fisico ma anche di quello della mente. Una natura come non l’avevo vista mai, così diversa da quella dolce e materna di casa mia. In queste dimensioni dilatate potevano solo svolgersi film dell’orrore, racconti di Stephen King in cui mostri senza nome si risvegliavano nel profondo delle foreste o dalle viscere della terra. Una natura senza passato nè presente, la natura dei primi o degli ultimi giorni dell’umanità. Una natura matrigna. Talmente presa ero dal mio nuovo amore da non vedere o non voler vedere, in questa perfezione, neanche il più piccolo difetto. Per esempio se l’America mi piaceva moltissimo, gli Americani invece mi davano qualche preoccupazione. Non capivo quello strano cocktail di entusiasmo, disponibilità e improvvisa freddezza. Mi sembrava che avessero reazioni molto diverse da quelle degli altri esseri umani. Aperture e chiusure improvvise e totalmente immotivate. Per dirla in breve mi sembravano alieni, gente venuta da un altro pianeta. Avevo viaggiato parecchio nel mondo anche in posti per cultura e tradizioni molto diversi dal mio, eppure mai mi ero sentita così diversa, così “altra”. Invece di spaventarmi però questa dissonanza mi atttraeva, mi incuriosiva, come un qualcosa che ti sfugge e che vorresti possedere. E poi c’era il cibo. E questo era veramente un punto dolente. Anni di paure e dubbi infantili si erano avverati. Miglia e miglia, giorni e giorni, pranzi e cene, di una monotonia straziante. Lì nel selvaggio West si consumavano solo carne e patate, qualsiasi altra verdura era scomparsa dal mondo. Nei casi migliori ottime bistecche alla griglia, nei peggiori, purtroppo molto frequenti, l’universo gastronomico sembrava ridotto solo ad hamburgers e patatine fritte. E poi c’era quell’odore, un odore indefinibile, un odore che mi sfuggiva come gli abitanti di quello strano paese. Un misto di scadenti olii fritti e di chimica andata a male. C’erano state è vero esperienze più varie e meno drammatiche. C’era stata Los Angeles dove però mia figlia aveva passato due giorni in bagno dopo aver mangiato ad un take away messicano e soprattutto San Francisco dove avevamo assaggiato il miglior pranzo cinese della nostra vita. Avevo anche tentato di preparare un piatto di spaghetti al pomodoro nella kitchenette di uno dei tanti motel in cui avevamo dormito. I risultati erano stati infeririori alle già basse aspettative. Gli spaghetti Ronzoni, gli unici onnipresenti nel Paese, passavano nel giro di tre secondi dall’essere immangiabili perchè crudi all’essere immangiabili perchè completamente scotti. Non parliamo poi dei pomodori, una vera tragedia nazionale, praticamente rape tinte di rosso e infine il parmigiano una “cosa” che si vendeva in barattoli verdi il cui sapore non aveva riscontri in natura. Per quanto tentassi di convincermi del contrario la verità era inconfutabile: in America si mangiava male. Eppure, anche in questo caso, cercavo le attenuanti: “Siamo stati particolarmente sfortunati, cattivi negozi e pessimi ristoranti!” ripetevo come un mantra a mio marito che, più smaliziato di me bofonchiava tra i denti “Già, veramente molto, molto sfortunati…..”
Per il resto fu una vacanza meravigliosa per tutti noi, l’America ci sembrava un’enorme parco giochi dove tutti, grandi e piccini avevano di che divertirsi, un posto in cui realtà e fantasia sembravano confondersi in continuazione. Un posto insomma dove poter essere felici. L’ultima notte, prima della partenza, nel mio letto, in silenzio per non svegliare Andrea, singhiozzavo disperata come chi è costretto ad abbandonare l’amore della vita senza sapere quando e se potrà mai rivederlo. Non mi era mai capitato prima. E mentre cercavo di prendere sonno mormoravo a me stessa: ” Prima o poi io qui ci verrò a vivere”.”
PER UNA RICETTA MOLTO AMERICANA, QUELLA DEL CORN BREAD CLICCATE QUI: RICETTA
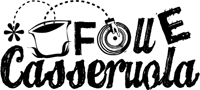

No Comments