A cambiare la nostra vita e il mio rapporto con il cibo fu anche l’acquisto di tre ettari di campagna vicino a Roma. Nella mia memoria bambina quel terreno, “Il Pratone” come fu immediatamente battezzato, era enorme, e in fondo abbastanza esteso doveva esserlo veramente se poi mio padre riusci’ a infilarci dentro la nostra grande casa, alcune stalle, l’abitazione del contadino, un recinto per i cavalli ( in realta’ frequentato per lungo tempo unicamente da Birillo, un pony orbo e grassissimo acquistato in un circo), un altro per i maiali, le capre, i conigli, i polli e le oche, oltre ad una cappelletta, a un forno a legna, ad una casetta per noi bambini, ad una pista di pattinaggio, ad un grande orto e a tanti alberi da frutta che mio padre pianto’ prima ancora di costruire la casa. All’inizio pero’ c’erano solo questo grande campo pianeggiante e un bosco di quercioli che a me sembrava fitto e pericoloso come quelli delle favole, anche se probabilmente non lo era affatto. Poi fu costruita la casa, grande, ampia e spaziosa che si affacciava a ferro di cavallo su un giardino curato con orgoglio da mia madre. Li’, in quel posto, mio padre realizzo’ un altro dei suoi sogni, quello di creare una grande famiglia patriarcale, tanti figli e tanti amici, su cui poter regnare benevolo. E ci riusci’ perfettamente. Per tutti gli anni di vita di quella casa molto amata, ruotammo intorno a lui come tanti pianeti intorno al sole. Era lui a portarci in giro per strade di campagna su uno scalcagnatissimo calesse trainato dal povero Birillo che, dopo anni di duro lavoro circense, avrebbe sicuramente sperato in una vecchiaia piu’ tranquilla. Era stato lui a costruire la pista di pattinaggio e la casetta sul cui tetto passavamo ore infinite fingendo di pescare da uno scoglio in mezzo al mare. Sempre lui aveva poi inventato le “corride” nel recinto degli animali. Vestito e bardato come El Cordobes, per l’occasione si era addirittura fatto confezionare una sorta di braghe imbottite, affrontava nell’arena, di fronte ad un pubblico in visibilio, (noi e i nostri amici), capre e caproni che afferrava per le corna ingaggiando feroci corpo a corpo finche’ i poveri animali non crollavano a terra esausti. Allora l’audace torero faceva il giro dell’arena per ricevere gli onori che gli spettavano. Ma soprattutto era lui che cucinava pasti pantagruelici. Quelle grandi mangiate degli anni ’60.
Mio padre, con la sua passione per la cucina, aveva fatto del “Pratone” un piccolo regno autonomo e indipendente. Tutto quello di cui avevamo bisogno veniva da li’. Carne, formaggi, latte, frutta, verdura, la tenuta produceva ogni cosa. Quegli anni sono stati per me una lezione mai dimenticata. La terra, l’avvicendarsi delle stagioni, il contatto con la natura, mi hanno insegnato a rispettare i loro immutabili ritmi. Gli animali, tutti, anche quelli che per periodi piu’ o meno lunghi dividevano con noi giochi e avventure, capretti, agnelli, conigli, prima o poi finivano in pentola, lo sapevamo ma questo non ci aveva mai impedito di apprezzare i succulenti piatti che mio padre preparava per noi. Faceva tutto parte della natura stessa delle cose.
Con il freddo si uccideva il maiale, ne sentivo le urla e me ne tenevo alla larga, pero’ assaporavo con gusto salsicce, lonze, prosciutti e salami che non mancavano mai sulla nostra tavola. Osservavo invece con interesse Antonio, il contadino, mentre tirava il collo ad oche e galline, lo faceva con un solo movimento, rapido ed indolore per gli animali, che non emettevano neanche un grido, poi praticava una piccola incisione sul collo e li lasciava a testa in giu’ a dissanguarsi. Mi sembrava un’impresa eroica e ne ammiravo soprattutto la precisione quasi chirurgica. Finche’ Antonio, vedendomi cosi’ interessata al soggetto, mi chiese se per caso non avessi desiderato apprendere la sottile arte dell’ammazza galline. Non ebbi esitazioni e tirai cosi’ il collo al mio primo pollo. Fu un lavoretto semplice e ben fatto e non nascondo di aver provato, in quegli istanti, un orgoglio particolare. Ogni tanto, per non perdere la mano, mi tenevo in esercizio, poi con la vendita del Pratone si interruppe anche questa intensa relazione con bipedi e pennuti. So che oggi tutto questo fa, un po’ ipocritamente, orrore ( qualcuno dovra’ pure ammazzarli quei polli che poi finiscono sulle nostre tavole), per quel che mi riguarda pero’ credo che la campagna e soprattutto il contatto quotidiano con quattro fratelli, in una famiglia tutta declinata al maschile, mi abbia vaccinato per sempre ( e con grande gioia ) contro qualsiasi tipo di “politically correct”.
Piu’ di ogni altra cosa pero’ la casa mi ha regalato profumi, aromi e sapori che mi avrebbero inseguito per il resto della vita perche’ quando si e’ assaggiata una pesca appena colta dall’albero, quella fragranza, quel gusto, lo si cerca poi all’infinito in ogni pesca che si incontra. In particolare amavo l’orto con le sue ondate di verdure, scandite come maree: c’era il momento dei cavoli, quello delle insalate, quello in cui venivamo sommersi da uno tsunami di fagiolini e, quello, il migliore fra tutti, in cui l’orto si tingeva di rosso: la stagione dei pomodori. Quello era il mio tallone d’Achille. Nelle calde giornate di luglio, quando il sole era piu’ giaguaro, mi sdraiavo tra i tralicci sulla terra bollente e staccavo uno dopo l’altro quei frutti cosi’ profumati, allora al culmine del loro splendore estivo, per mangiarli a grossi morsi lasciando che il loro succo ardente colasse ovunque. L’aroma e il gusto erano cosi’ intensi che li assaporavo in silenzio, a occhi chiusi, per potermi concentrare meglio su quell’unica, acutissima nota. Non erano pomodori, erano vere boccate di sole.
A Oriolo mio padre cucinava con fervore appassionato. Le domeniche erano le sue giornate gloriose, quelle in cui la casa si apriva agli amici e si mangiava fino allo stordimento. Arrivavano, per la cerimonia, intere carovane cammellate di adulti e bambini, mai meno di una trentina di persone, mentre mio padre cadeva vittima di una frenesia convulsa sin dalle prime ore del mattino. Venivano affettati interi prosciutti, e poi lonze, coppe e mortadelle, salamini e salsiccette, teglie enormi di lasagne entravano e uscivano dal forno a legna fatto costruire in giardino, probabilmente l’edificio piu’ frequentato della casa. E poi polli, quantitativi pantagruelici di polli che erano oliati, conditi, speziati, avvolti in larghe fette di pancetta e massaggiati per ore. Mio padre amava massaggiare tacchini e pollastrelli, sostenendo che cosi’ facendo le carni si ammorbidissero diventando piu’ saporite. Non so se questo fosse effettivamente vero, sta di fatto pero’ che quelli furono sicuramente i polli migliori che io abbia assaggiato. Piu’ di ogni altra cosa a sconcertarmi poi era l’ espressione rapita che gli illuminava il viso mentre con ardore palpava volatili, era evidente che quel contatto fisico gli piaceva veramente. Oggi massaggio polli anch’io e quando lo faccio, perlomeno cosi’ sostengono i miei figli, cado anche io in uno stato di trance incantato.
Comunque sia, quelli di Oriolo non erano pranzi come gli altri ma piuttosto banchetti trimalcionici dove si assaltavano capretti, conigli e agnelli interi, poi tacchini ripieni, ciclopici arrosti di maiale, mastodontiche pignatte di pasta e fagioli e quintali di patate al forno. Nelle domeniche invernali invece era la volta di enormi paioli di polenta versati direttamente su un grande tavolo di legno le cui estremita’ erano state scavate a formare una sorta di mezze grondaie dove venivano scodellate spuntature e salsicce. Ci si accalcava intorno con foga impaziente, chi con mestoli e forchette, chi direttamente con le mani. Non ci si fermava finche’ il tavolo non fosse tornato pulito. Nessuno sembrava avere, in quel periodo, problemi di linea, diete da osservare o problemi di digestione, anzi, la gioia, a pranzo concluso, era quella di poter esibire ventri pieni e stomaci dilatati. La fame, quella atavica, era finalmente estinta e questa nuova sazieta’ la si ostentava con una certa fierezza.
Mia madre, che lasciava volentieri a mio padre lo scettro della cucina, pensava invece a conserve e marmellate. Avevamo una dispensa fornitissima che annoverava legioni di scintillanti barattoli di salsa di pomodoro, di frutta sciroppata e di marmellate. Su quest’ultime mia madre esprimeva al meglio la sua vena creativa. Ce ne erano di pesche, di prugne, di fragole, di albicocche e soprattutto quelle, a tutt’oggi restate ineguagliate, di fichi. Proprio a quest’ultime devo un altro di quei compiuti momenti che sfidano tempo e spazio per continuare a vivere di vita propria in una sorta di universo parallelo.
E’ un caldo pomeriggio di fine luglio, la casa e’ immobile e silenziosa nella calura estiva, gli altri, genitori e fratelli, celebrano, insieme a milioni di Italiani il patriottico rito della “pennica” post prandiale. Ho otto o nove anni, troppi o troppo pochi per desiderare il conforto del sonno pomeridiano, il mondo ha ancora tante sorprese in serbo per me. Cosi’ approfitto di quelle ore quiete per starmene sdraiata sul divano del soggiorno, un cuscino sotto alla testa, a leggere un libro, uno dei mie passatempi preferiti. La stanza e’ immersa nella penombra nel tentativo di resistere all’implacabile assedio dell’afa che non da’ tregua. Da fuori mi arrivano suoni e brusii un po’ infiacchiti dalla canicola. Il ronzio ubriaco delle api e il frinire isterico delle cicale. Mi sento anche io molle e intorpidita, priva di desideri se non quello di restare li’ per sempre, in quella posizione, in quella particolare giornata, a leggere Ben Hur. Sono agli ultimi capitoli del libro, Ben, principe degli Hur, torna, dopo anni di peripezie, nella casa di famiglia, ormai vuota e cadente, e incontra Esther, l’indimenticato amore, che gli rivelera’ il grande segreto: Miriam e Tirzah (rispettivamente madre e sorella di Ben), non sono morte ma lebbrose. Prima di affrontare quest’ultima, clamorosa rivelazione decido pero’ di avere fame, cosi’ mi preparo una fetta di pane casareccio spalmato di burro e marmellata di fichi. Mi sdraio nuovamente nella penombra e mentre stacco un grosso morso, una parte del mio cervello registra che la marmellata e’ fresca e dolce, con un sottofondo asprigno e leggermente affumicato, che il burro e’ morbido e pastoso, che il pane e’ caldo e croccante e che gli insetti continuano a brusire nell’aria immota, e intanto io penso: “ Eccomi, sono qui e sto vivendo un attimo perfetto, forse questa e’ la felicita’ e da grande dovro’ ricordarlo”. E infatti crescendo non ho dimenticato che a volte la felicita’ si puo’ cercarla e trovarla anche in una fetta di pane, burro e fichi.
DA: “COSI’ MANGIAVAMO” DI STEFANIA APHEL BARZINI-EDIZIONI GAMBERO ROSSO.
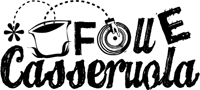

No Comments