DA:”UNA CASALINGA AD HOLLYWOOD”.STEFANIA BARZINI-EDIZIONI GUIDO TOMMASI.
Ai primi del’94 decidemmo che era giunto il momento del grande salto: destinazione Los Angeles dove volevamo trasferirci a tempo indeterminato.
Andrea partì per primo alla ricerca di una casa. Io l’avrei raggiunto da lì a poco, dopo aver organizzato il trasloco e spedito le nostre suppellettili. I miei figli sarebbero arrivati in seguito accompagnati da mia madre decisa a darci una mano per il primo mese.
Non volevamo portare mobili ma solo abiti e oggetti che aiutassero a farci sentire un pò più vicini a casa. Naturalmente per me questo voleva dire imballare pentole, piatti, utensili di cucina e soprattutto tutti i miei libri di ricette. Non avevo nessuna intenzione di piegarmi alle manie e alle mode culinarie americane, io avrei cucinato, come avevo sempre fatto, perchè la mia infantile fissazione per il cibo si era naturalmente evoluta in altrettanta ossessione per la cucina. Cucinare, nutrire amici e parenti mi era diventato vitale e necessario quanto il mangiare.
Sistemare la casa e organizzare la partenza, anche se faticosi, non furono i problemi maggiori da affrontare. C’erano i miei figli e le loro reazioni. Se infatti Matteo, allora undicenne, si era mostrato subito entusiasta all’idea del cambiamento (adorava l’America, era un patito della sua musica e un fan sfegatato dei Chicago Bulls), Chiara, al contrario, nel pieno di quella che viene chiamata “età difficile”, ne aveva fatto un dramma. Per evitare questa partenza le aveva provate tutte, aveva supplicato, implorato, pianto, urlato, puntato i piedi, sbattuto porte e finestre, finchè esausta aveva giocato l’ultima carta: “Vogliamo parlare della politica estera americana?” aveva esclamato tra le lacrime, tentando di far leva sulla nostra anima sessantottina. Ma noi, per l’appunto, avevamo già dato, e in quel momento l’imperialismo americano era l’ultimo dei nostri pensieri.
Così, malgrado le ansie e le paure di mia figlia che speravamo si sarebbero placate una volta toccato il suolo straniero, arrivò il giorno della mia partenza.
Andrea mi aveva telefonato per dirmi che forse aveva trovato la casa giusta e aspettava il mio arrivo per mostrarmela.
Dall’aereo che si alzava in volo guardavo allontanarsi l’Italia con un misto di nostalgia e di eccitazione. Ero già lontana.
L’atterraggio a Los Angeles mi sembrò durare ore, presa com’ero a osservare la sfilata interminabile di strade, macchine e casette tutte uguali. La prima voce americana che mi accolse all’aereoporto fu quella monotona di un altoparlante che ripeteva come un disco rotto: “Keep eye contact with your belongings” (“Mantenete il contatto visivo con i vostri averi”). In pratica “Cercate di non farvi fregare le valige”. Il primo, fulgido esempio di linguaggio “politically correct”. Non un inizio rassicurantissimo. Ciò che invece mi colpì come una frustata uscendo all’aperto fu la luce, violenta e aggressiva, e quel vento, secco, ardente, cattivo, senza requie.
Il Santa Ana soffia da nordest, attraversa il deserto e si rovescia come olio bollente su Los Angeles. Estate e inverno, senza preavviso se non una strana immobilità dell’aria. E’ un vento da terremoto, da incendi, da omicidi. Un vento che mette a nudo i nervi come lo scricchiolio del gesso sulla lavagna. Quando soffia il Santa Ana la gente a Los Angeles resta acquattata nelle case, l’aria condizionata va al massimo, il mare sembra una lastra di metallo, la percentuale di morti violente, già alta in tempi normali, raddoppia.
“In notti come queste,” scrisse una volta Raymond Chandler parlando del Santa Ana, “ogni party ad alto tasso alcolico finisce in rissa. Mogli di solito timide e mansuete, sfiorano la lama del coltello di cucina osservando con attenzione il collo dei propri mariti. Qualsiasi cosa può accadere.”
Così, sospinti dal vento caldo, arrivammo alla nuova casa.
Langdon Avenue sta in quella che, per la maggior parte dei Losangelini, è la parte sbagliata della città: the Valley, la Valle, vale a dire al di là delle colline che racchiudono il dorato mondo di Bel Air e Beverly Hills. Francamente non ho mai capito questa divisione tra città “bene” e città “male”. Non a Los Angeles che certo non è tra le più belle città del mondo, nè al di qua nè al di là delle colline.
A Los Angeles di bello c’è il mare, la luce, la natura e l’immaginario di chi ci abita che varia a seconda della quantità e della qualità dei film americani che ciascuno ha visto nel corso di una vita. I film restano, la luce, il mare e la natura cambiano di volta in volta. Quando c’è la nebbia (che nella parte “bene” della città cala molto più spesso di quanto non si creda), quando il cielo è coperto e quando piove, L.A. diventa una delle città più tristi e più brutte del mondo. Nella parte “male” della città invece il sole batte inclemente e caldissimo per la maggior parte dell’anno. Un sole e una luce che coprono e appiattiscono lo squallore annidiato agli angoli delle strade.
Langdon Avenue fa parte di un’area della Valle che viene pomposamente chiamata “Midvale Estate”. Una volta questo agglomerato di casette, steccionate in legno, prati e alberi perennemente fioriti, faceva parte di una sola proprietà. Una volta, tempo fà, Midvale Estate era un aranceto. Adesso gli aranci sono pochi, spazzati via dall’arrivo della 405, l’autostrada che taglia la Valle, che a sud porta a San Diego e a nord congiunge Los Angeles a Sacramento. Oggi l’Estate è un pezzo di America anni ’50 assediato dalla cayenna che l’assedia ai fianchi: una folla di diseredati, per lo più poveri emigranti del sud e del centro America. Un’umanità che parla spagnolo, mangia tacos e si arrabatta per ritagliarsi un pezzo di sogno americano pulendo i giardini e le case della città “bene”.
Il 6625 di Langdon Avenue mi conquistò al primo sguardo. Una villetta di legno a un solo piano, dipinta di bianco e azzurro; davanti un prato di erba tagliata e una grande quercia, sul retro ancora prato con alberi di prugne, pompelmi, arance, limoni e moltissimi scoiattoli. Il colpo al cuore però lo ebbi entrando: quella era la casa di Lassie! Pavimenti di legno, due camini (con quel caldo!?), la porta finestra sul retro identica a quella a cui si affacciava Ruth per avvertire che il pranzo era pronto e soprattutto …..la cucina!! Una vera, grande cucina anni ’50, una cucina che, si capiva, aveva molto lavorato. C’era anche un ripiano in legno per fare il pane e la pasta e, a farmi battere il cuore, una vera “soda fountain”, una macchina a motore con un sifone da selz e tanti cilindri in acciaio cromato dove tenere al fresco gelati e sciroppi; un oggetto che forse a noi italiani diceva poco ma che immancabilmente inumidiva gli occhi di qualsiasi americano che entrasse in casa mia, dall’idraulico agli amici, testimone vivente di un’ America scomparsa ma mai dimenticata.
Quella era la mia casa ed io ero Ruth, pronta ad indossare il grembiule e mettermi ai fornelli.
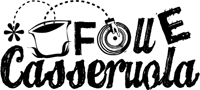

No Comments